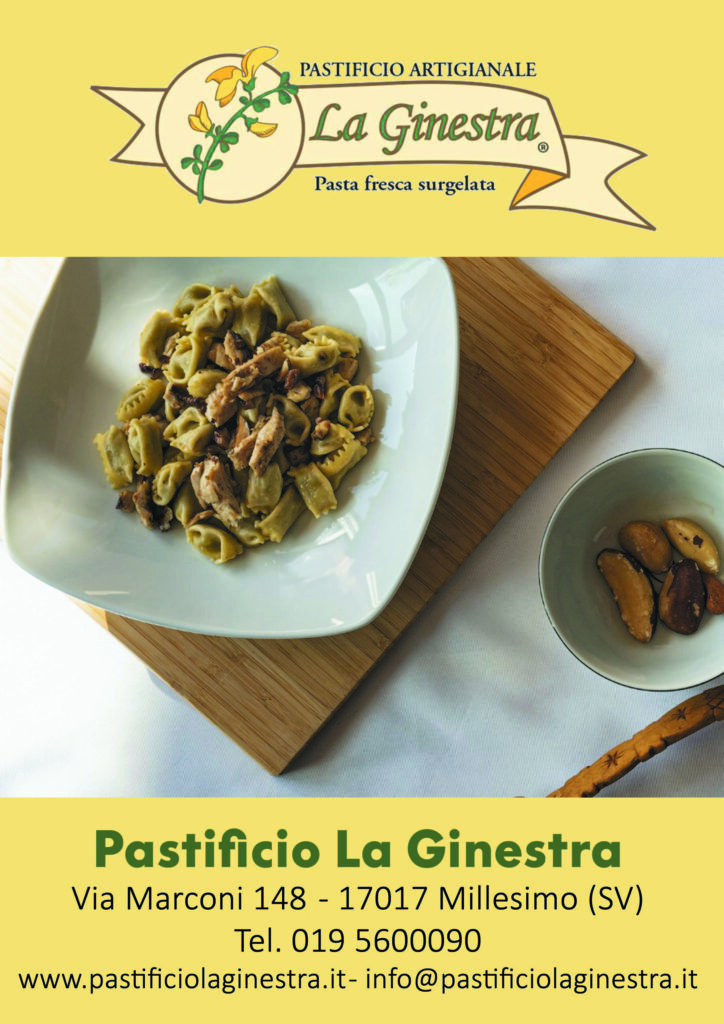di Antonello Catani
Introduzione
Fin da tempi remoti Eros è stato percepito come un nume bifronte, e cioé, come portatore di gioie ma anche di sventure. Questi suoi lati contradditori sono stati cristallizzati dall’immaginario collettivo e dalla finzione poetica in innumerevoli vicende d’amore, i cui epiloghi sono molto spesso luttuosi o violenti. Un alone inquietante ha dunque da sempre circondato la sua figura.
Naturalmente, la civiltà moderna, sempre più imbevuta di ciò che è stato felicemente definito come “allegro tecno-corporativismo”,1 tende a ignorare questi ultimi aspetti. I suoi miti più accreditati, il ‘benessere’ e il ‘progresso’, cozzano incoercibilmente con qualsiasi prospettiva che possa offuscare il loro smagliante ottimismo. E tuttavia, nonostante il trascorrere dei millenni e il progressivo sbiadire di innumerevoli superstizioni e fobie, nell’immaginario collettivo continua ad affiorare l’oscura percezione che dietro le voluttuose maschere di Eros si celi in realtà un volto assai più fosco e temibile.
Già: nell’immaginario… Ciò che la società esorcizza sotto il manto dell’idealismo e del moralismo, riemerge molto spesso con ribelle intensità sotto le spoglie apparentemente innocenti e casuali della finzione narrativa o del mito. Sia l’uno che l’altra agiscono infatti come imprevedibile cassa di risonanza di complessi psichici rimossi dalla coscienza o comunque minimizzati dalla cultura ufficiale. Un esempio emblematico di questi ultimi è rappresentato dall’ambivalente atteggiamento di attrazione ma anche di diffidenza nei confronti di Eros, che sembra essere una costante di indefinibile antichità, non solo nell’immaginario della cultura occidentale ma anche al di fuori di essa.
I sintomi di tale ambivalenza sono percepibili già nel modo stesso con cui letterattura e mito tendono in genere a rappresentare la passione d’amore. Nonostante quest’ultima sia inestricabilmente composta di sentimenti e di desiderio fisico, in genere, sono i primi ad essere descritti, e non il rituale sessuale. Anzi, più la storia è tragica, e più quest’ultimo si sfoca, diventa del tutto insignificante e, in ogni caso, viene prudentemente velato. Mentre tale costante ha, come vedremo, delle implicazioni assai vaste e imprevedibili, essa tradisce l’esistenza di un conflitto fra due piani, in teoria complementari ma in pratica irriducibilmente opposti: quello della vibrazione sentimentale da una parte, e quello del desiderio fisico dall’altra o, detto in altre parole, quello dell’anima e quello del corpo. In realtà, tale conflitto, che si potrebbe anche definire come ‘il complesso di Eros’, ha sempre agito (e continua ad agire) sotto la superficie della coscienza collettiva e dei costumi, con i travestimenti più disparati. I suoi due poli, infatti, l’attrazione e il rigetto, possono assumere ora la forma della più esasperata sensualità oppure dell’estrema idealizzazione sentimentale, del fascino o della censura moraleggiante, della valorizzazione religiosa oppure della più ostile persecuzione. Da tempo immemorabile l’immaginario collettivo continua ad essere il fedele registro di tali oscillazioni, fornendone inesauste ma anche invariabili repliche.
La passione erotica, insomma, affascina, ma la sua piena realizzazione è in genere ostacolata e il suo destino, tragico. Perché? Cosa si nasconde dietro tale conflitto e i suoi epiloghi quasi sempre luttuosi?
Vista l’ossessiva ricorrenza di tutti questi elementi nell’immaginario narrativo, ci si potrebbe attendere che la storia della letteratura, la psicologia e la filosofia dedichino ad essi un’attenzione privilegiata.
In realtà, le cose non stanno affatto così: nostante il tema della passione erotica affiori ad ogni piè sospinto nelle opere più svariate, antiche e moderne, la storia della letteratura tende infatti a liquidarne sbrigativamente con l’etichetta di “tragico” gli aloni più foschi, relegandone gli aspetti più sfacciatamente sensuali negli scaffali proibiti dell’erudizione “curiosa”. Contagiata dalla millenaria avversione della dottrina ecclesiastica nei confronti della sessualità, e sterilizzata dal cerebralismo della speculazione filosofica che, nonostante intermittenti empirismi di varia estrazione, continua in realtà a dominare la storia delle idee, l’attenzione dello storico-critico si ferma di solito alle componenti estetico-sentimentali delle varie vicende amorose, ma senza andare oltre. Le componenti sensuali della passione e l’intimo conflitto che le pervade sono curiosamente lasciati in ombra. Si tratta solo di una limitazione professionale e metodologica oppure, come vedremo, questo atteggiamento è anch’esso collegato a una diffusa diffidenza della cultura dominante nei confronti dei lati più inquietanti di Eros?
In realtà, nonostante Platone gli abbia dedicato due ambigui dialoghi, buona parte del successivo pensiero occidentale ha ignorato la dimensione erotica, considerandola priva di dignità ontologica, e ha concentrato invece la sua attenzione su livelli più astratti o comunque più idealizzati. Per millenni, dunque, la lente e la prospettiva sono stati i sentimenti, l’anima, la mente, il pensiero, le categorie, gli Enti, ma non il ruolo oscuro delle pulsioni erotiche e ciò che sta dietro di esse. Anche se Schopenhauer e Freud apparvero come meteore ad illuminare gli aspetti più torbidi e inquietanti di tale dimensione, le prospettive da loro aperte continuano a rimanere scarsamente utilizzate per interpretare la storia della civiltà e, in particolare, la finzione romanzesca. Anche un’opera come Life against death di Norman Brown, pur così intensamente focalizzata sul tema di Eros, trascura di esplorarne le innumerevoli manifestazioni letterarie.2
In realtà, per quanto snobbato dalla cultura ufficiale, quel tema è così presente nella storia della civiltà da essere ubiquo e comportarsi da uccello migratore, come dimostra la disinvoltura con cui esso può scavalcare le fittizie limitazioni dei generi e superare sia le frontiere culturali che quelle geografiche. Oltre che nel mito antico e nelle affabulazioni dei poeti e dei romanzieri moderni, le sue tracce sono infatti ben visibili non solo nelle arti figurative e nelle esortazioni dei Dottori della Chiesa ma anche nelle parole stesse dei filosofi. Di fronte a tale radicata ecumenicità, l’unico efficace criterio per esplorarne le vicende rimane quello comparativo, anche a costo di forzate generalizzazioni, semplificazioni e omissioni. Il materiale teoricamente a disposizione è del resto così prodigiosamente ricco e vario che una sua più esauriente rassegna richiederebbe, oltre a dei grossi volumi, anche la padronanza di un numero scarsamente sottostimabile di lingue e culture, padronanza che l’autore delle presenti pagine non intende certo rivendicare. Vista inoltre la brevità di questo scritto, è ovvio che esso dovrà anche trascurare le specificità dei diversi contesti storici, concentrando invece la sua attenzione solo sulle forme di volta in volta assunte dal complesso di Eros.
E qui varrà la pena di accennare brevemente ad alcuni elementi.
E’ ben noto come la cultura moderna nutra una viscerale diffidenza nei confronti delle ricerche poco o affatto “storicizzate”, dove per “storicizzate” si intende un qualche grado di identificabile correlazione causa-effetto fra l’ambiente-epoca e il fenomeno preso in esame. Questo approccio, assai efficace se applicato alle tecniche della ceramica e della pittura, ai metodi di coltivazione e di allevamento o all’evoluzione delle singole lingue, si mostra tuttavia più fragile quando la suddetta correlazione riguarda fenomeni più complessi. Un esempio emblematico è rappresentato dal sorgere e dal fulmineo diffondersi dell’Islàm: nonostante tutte le varie cause di volta in volta addotte per spiegarne il fenomeno – dalla debolezza dell’Impero Sassanide e di quello Bizantino alla crescente aridità della Penisola Araba o alla maggiore efficacia del leggero cavaliere arabo rispetto alla più pesante cavalleria persiano-bizantina – tali cause puntuali, da sole o assieme, non spiegano quell’improvviso espandersi. Senza la comparsa di Maometto e l’effetto catalizzatore del suo inusitato messaggio, molto probabilmente, l’Islàm non sarebbe mai nato.
Ma a sua volta, anche quel messaggio è solo in parte riconducibile a specifiche e puntuali influenze – brandelli di episodi biblici e di rivelazione cristiana, costumi tribali, leggende locali o anche esigenze pratiche – che nuovamente non ne spiegano la comparsa, salvo rimandare a elementi ben più insondabili, costituiti appunto dalle emozioni, dai sentimenti e dalla capacità del Profeta di riplasmare tutto ciò in un qualcosa di diverso e di nuovo. E qui, evidentemente, ogni approccio storicistico si rivela ancora più inadeguato, perché i suddetti elementi suggeriscono a loro volta l’esistenza di una sorta di quantum psichico impervio a ogni puntuale correlazione.
Detto in altri termini, fino a che punto certi complessi psichici sono insomma meccanicamente condizionati dal contesto materiale, normativo e sociale, e sono invece collegati a pulsioni assai più profonde e meno razionalizzabili? In realtà, sembra che esista una soglia, oltre la quale l’animo umano si sottrae alle deduzioni e ai collegamenti puntuali.
Così, giusto per fare un esempio più vicino al nostro argomento, la percezione di un greco antico nei confronti di certi lati di Eros era condizionata solo dallo specifico clima culturale? Se così fosse, rimarrebbe sempre da spiegare come mai percezioni analoghe fossero condivise anche da uomini di civiltà ed epoche differenti e siano inoltre sopravvissute fino ai nostri giorni senza significativi cambiamenti. In fondo, uno dei nostri obbiettivi sarà proprio quello di esplorare tale sconcertante continuità e convergenza di atteggiamenti. La loro curiosa inelasticità nei confronti del divenire storico tocca fra l’altro il cuore stesso della civiltà moderna, i suoi più gelosi postulati. Dietro le consolanti prospettive di una Storia invariabilmente risultato di elementi socio-ambientali, ricostruibili ma perciò anche tendenzialmente modificabili, si annida infatti lo strisciante miraggio rappresentato dalla possibilità di indirizzare, correggere e migliorare tale Storia e tutto ciò che essa contiene, nozione che rappresenta il fulcro dell’idea di “Progresso”. Ma questa idea implica a sua volta un’ulteriore nozione, ancora più sottile, e cioè, che non debbano e non possano rimanere ombre di nessun genere nella direzione di tale “Progresso”.
Ora, ogni ricerca che in qualche modo suggerisca, anche senza affermarlo, il prepotente ruolo di elementi irrazionali o curiosamente ribelli ai condizionamenti storici non può che disturbare un simile ottimistico modello. Infatti, come modificare e migliorare ciò che appare misteriosamente imprevedibile, anarchico e, perciò, anche in qualche modo demoniaco? Nonostante la fisica quantistica abbia mostrato la fragilità di ogni rigido meccanicismo e di come i livelli sub-atomici della materia siano in realtà costituiti da energie anch’esse imprevedibili quanto evanescenti, la civiltà moderna continua in realtà a perseguire l’eliminazione mentale dei demoni di vecchia memoria, sostituendoli con procedure e criteri rigidamente fissati e controllabili.
Non c’è quindi da stupirsi se anche i lati più oscuri e torbidi di Eros sono inclusi in quel processo di eliminazione, che ne salva solo elementi depurati e idealizzati: se questi ultimi non inquietano, non è tanto perché essi sono eticamente lodevoli, ma piuttosto perché sono controllabili e prevedibili.
Insomma, è evidente come il terreno esplorato in questo saggio sia disseminato di fantasmi di solito esiliati e mistificati. Del resto, se cercheremo di ritrovarne le tracce soprattutto nell’immaginario romanzesco, non è perché la nostra prospettiva di fondo e i nostri scopi siano specificamente letterarî. Semplicemente, per quanto ancora una volta filtrati e mascherati, è proprio nella finzione dell’immaginario che i sintomi del ‘complesso di Eros’ sono più chiaramente riconoscibili.
Come si vede, le limitazioni e le peculiarità fin qui elencate non sono nè poche nè insignificanti. E tuttavia, se anche da questo approccio ibrido, sintetico e a volo d’uccello emergeranno, inseriti in una prospettiva non idealistica, certi lati in genere trascurati del conflitto inerente la figura di Eros nell’immaginario dell’occidente, la nostra esplorazione avrà raggiunto il suo modesto obbiettivo.
18 aprile 2025
1 Cfr. Jonathan Frantzen, Come stare soli, Torino 2003, p. 91.
2 Cfr. Norman O. Brown, Life against death, London 1960.