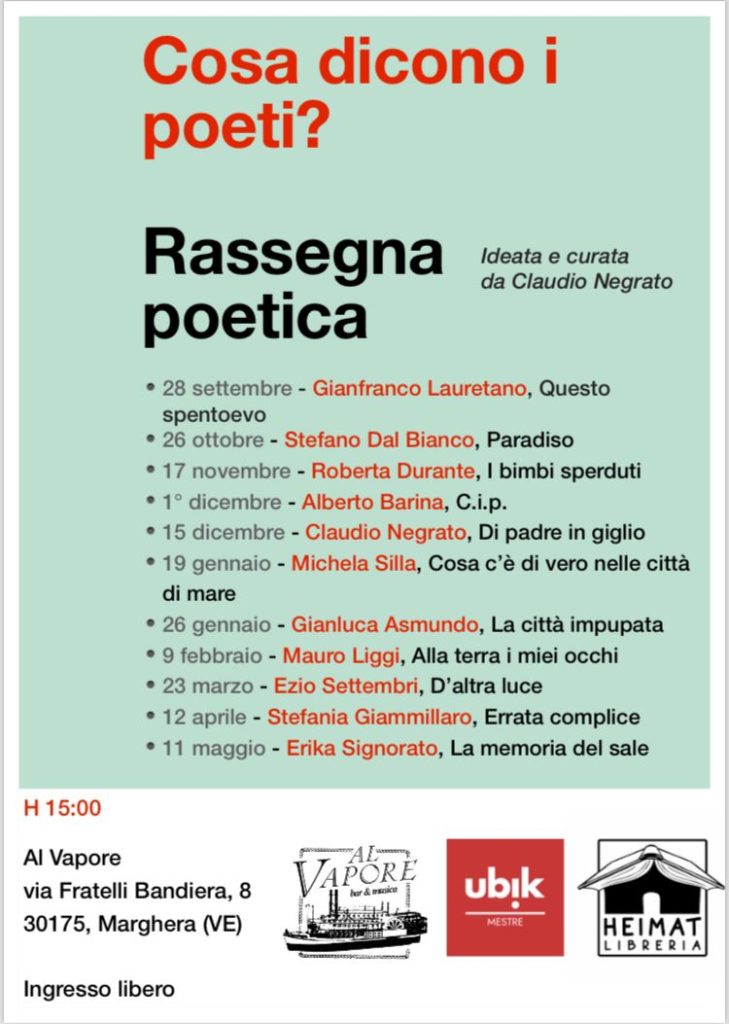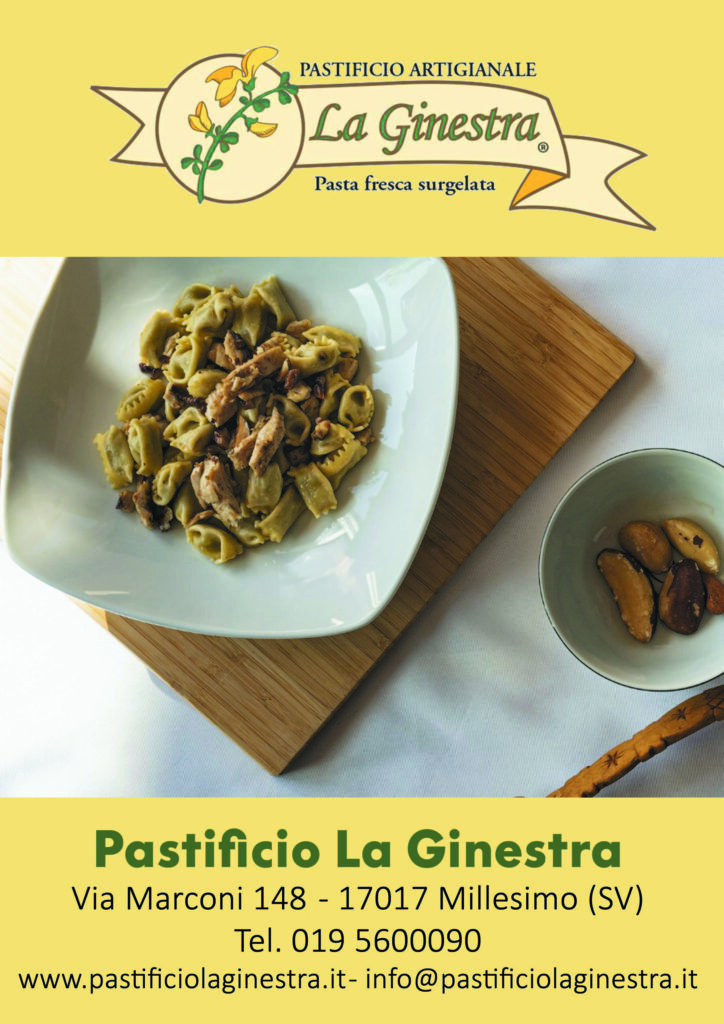di Patrizia Lazzarin

Alle Gallerie dell’Accademia di Venezia è in programma la mostra Stupore, realtà, enigma. Pietro Bellotti e la pittura del Seicento a Venezia che si terrà dal 19 settembre 2025 al 18 gennaio 2026. Curata da Francesco Ceretti, Michele Nicolaci e Filippo Piazza, l’esposizione presenta al grande pubblico, inserendolo all’interno del contesto artistico straordinario della pittura lagunare del pieno Seicento, il pittore bresciano, Pietro Bellotti (1625-1700), attivo a Venezia per la maggior parte della sua carriera e ancora poco noto, ma di indubbio fascino.
La mostra racconta la nascita e lo sviluppo, nella Venezia di metà Seicento, di un nuovo modo di interpretare temi e soggetti propri dell’immaginario barocco, dove la predilezione per iconografie inconsuete si associa a un’acuta osservazione del dato reale, creando un affascinante connubio tra “stupore” e “realtà”.
Entrambi questi elementi sostanziano l’opera di Bellotti ed emergono in due importanti dipinti a lui riferibili, acquisiti di recente dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia: si tratta del cosiddetto Autoritratto come allegoria dello Stupore, una sorta di eccentrica presentazione ufficiale del pittore nell’agone pittorico veneziano, e dei Popolani all’aperto, prototipo della “pittura di realtà” e capolavoro della scena di genere, che costituisce un ponte con la celebre produzione del milanese Giacomo Ceruti di inizio Settecento.

Pietro Belotti, Autoritratto come allegoria dello stupore
Quest’ultima tela, in particolare, è da tempo al centro di un complesso dibattito attributivo al quale la mostra intende fornire un contributo di primo piano, anche sulla base degli esiti del recente restauro.
Da questa particolare congiuntura, che talvolta rivela degli “enigmi” interpretativi, deriva la possibilità di compiere un inedito percorso attraverso la pittura veneziana d’età barocca, grazie ai prestiti eccezionali concessi da musei internazionali e italiani, quali il Museo Nacional del Prado di Madrid, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, la Staatsgalerie di Stoccarda, il Dallas Museum of Art, le Gallerie degli Uffizi di Firenze e il Castello Sforzesco di Milano.
Questi prestiti, oltre che tratteggiare il percorso pittorico di Bellotti, consentono di istituire importanti confronti con alcuni tra i massimi protagonisti del tempo, tra cui Ribera, Giordano, Cagnacci e Langetti attivi, o legati, a Venezia dove si distinse uno specifico gruppo di artisti che in qualche modo dialoga sia con le straordinarie invenzioni bellottiane sia con la contemporanea scena lombarda, richiamata in mostra da pittori come Monsù Bernardo e il cosiddetto Maestro della tela jeans.
In questo senso, l’evento rappresenta una preziosa occasione di riflessione e, al tempo stesso, un imprescindibile momento di sintesi nel contesto della cultura figurativa del Seicento. Una stagione segnata, soprattutto a Venezia, dalla fioritura di nuove correnti espressive alimentate, per molti versi, anche dai dibattiti letterari e filosofici sorti all’interno delle accademie che ribadiscono, una volta di più, lo stretto rapporto che intercorre tra pittura e letteratura. Un itinerario di per sé articolato che contribuisce al fascino senza tempo della pittura di Bellotti, caratterizzata da soggetti misteriosi, spesso legati alla negromanzia, alla filosofia e all’esoterismo.
La rassegna, inoltre, si pone in continuità con il recente riallestimento delle sale delle Gallerie dell’Accademia dedicate alle collezioni del Sei e Settecento (2021) e ai due convegni scientifici su temi seicenteschi organizzati nel biennio successivo. «Si tratta – sottolinea Giulio Manieri Elia, direttore delle Gallerie dell’Accademia – di una mostra ambiziosa, la prima che la città dedica alla pittura del Seicento veneziano dopo la grande rassegna del 1959. È un lavoro di studio e di ricerca, ma anche di fondamentale valorizzazione delle opere delle nostre collezioni, nel solco di quel percorso di riscoperta sul Seicento veneto cominciato con il riallestimento delle sale al piano terra e con i due convegni negli anni seguenti.»
L’esposizione, che si avvale di un comitato scientifico di alto profilo – che comprende Linda Borean, Francesco Frangi, Fabrizio Magani, Giulio Manieri Elia e Alessandro Morandotti – sarà accompagnata da un catalogo curato da Francesco Ceretti, Michele Nicolaci e Filippo Piazza, corredato da saggi di noti studiosi italiani.
La mostra è promossa e organizzata dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia.