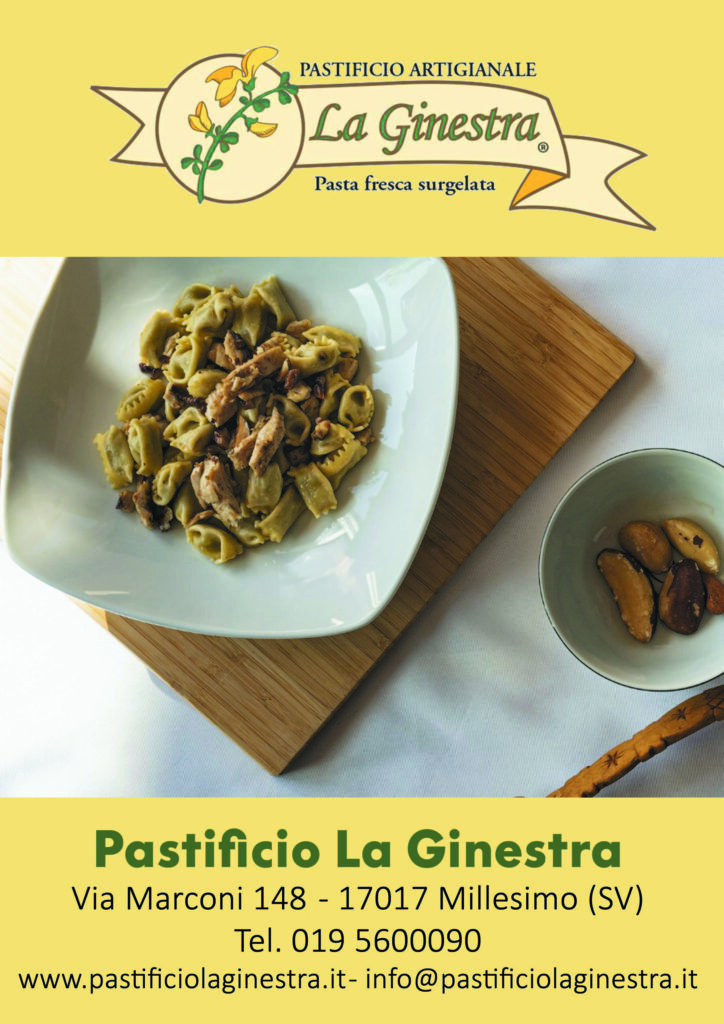di Antonello Catani
La mania tariffaria di Donald Trump non è nuova. Essa era già all’opera , sia pure in misura più blanda, durante il suo primo mandato. Adesso la mania si è trasformata in una guerra, figlia a sua volta di uno slogan pubblicitario: “MAGA” ovvero “Facciamo nuovamente grande l’America” con tanto di berrettini rossi. Il lato teatrale di questi ultimi è a sua volta l’istrionico figlio del passato televisivo di Donald Trump.
In altre parole, MAGA è prolifica e ha partorito molti figli e figlie: la minaccia di annettere il Canada, il progetto di annessione di Gaza e della Groenlandia, il cambiamento di nome al Golfo del Messico (ora American Gulf ), etc.
Noti economisti americani, fra cui Jeffrey Sachs, Richard Wolff, Thomas Sotwell, Michael Hudson e la ex responsabile della Banca Federale, Janet Yellen, giusto per citare alcuni nomi, hanno messo in luce le inconsistenze e i rischi della suddetta guerra. Le lamentele di Donald Trump, secondo cui gli Stati Uniti sarebbero “sfruttati” dal resto del mondo e i suoi progetti di re-industrializzazione degli Stati Uniti non hanno fondamento e proiettano l’illusione che quella che è ormai un’economia di servizi possa magicamente fare marcia indietro e ridiventare un’economia manifatturiera. Non a caso, mentre Trump tuona contro il deficit commerciale, egli trascura di menzionare che da almeno 20 anni gli Stati Uniti hanno un significativo surplus nell’esportazione di servizi.
In realtà, se circa 3000 società americane, a parte moltissime altre di vari Paesi, hanno trasferito le loro attività produttive all’estero (vedi Cina, Vietnam, Corea del Sud, Mexico, etc.), il motivo è banale: minori costi di produzione e maggiori profitti. Il risultato sono prezzi attraenti che inducono quindi il consumatore finale ad acquistare quei beni. Lo stesso vale per beni provenienti da produttori di altri paesi, che offrono prezzi competitivi rispetto a quelli domestici.
In altre parole, il regime americano dei prezzi dei beni e servizi a parità d prodotto e condizioni è molto spesso di gran lunga più alto di quello del resto del mondo (vedi per esempio le prestazioni mediche.)
Sostenere allora, come fanno Trump e i suoi docili Consiglieri, che il cosiddetto “Giorno della Liberazione” segnerà la rinascita dell’industrializzazione americana appartiene al mondo degli abbagli e delle proiezioni pubblicitarie. Il crollo delle borse e le colossali perdite ora in parte recuperate sono solo una delle conseguenze del repentino aumento dei dazi basato sulla bizzarra percentuale delle importazioni rispetto alle esportazioni. D’altra parte, se l’inattesa pausa di 90 giorni con tariffe generalizzate del 10% (salvo la Cina ormai al 125%) ha provocato un rialzo verticale delle borse, essa non eliminerà il clima d’incertezza che la guerra tariffaria ha innescato. Il trauma è profondo. Gli investitori non lo dimenticheranno. Le velleità protezionistiche di Donald Trump sono non meno devastanti della politica di sostegno all’Ucraina del suo predecessore.
La spasmodica e truculenta punizione tariffaria perseguita dalla Casa Bianca, che scardina decenni di libero commercio, e l’erratico decisionismo del Presidente rimandano infatti a scenari di lungo termine e più profondi del recente crollo delle borse e cioè al cristallizzarsi di un generale clima di sfiducia e incertezza economica a livello mondiale. Ciò vale sia per le operazioni industriali che per il mercato finanziario. Non è un caso che sia in Giappone che in altri Paesi asiatici siano avvenute massicce vendite di buoni del tesoro americani, cosa che verosimilmente è la causa dell’inatteso freno temporale degli aumenti tariffari. Anche il progetto della Bundesbank tedesca di rimpatriare circa 112 miliardi in oro attualmente custoditi negli Stati Uniti sembra coincidere col suddetto clima di prudenza se non di vero e proprio timore.
Ancora delle osservazioni economiche.
Si sa che il debito pubblico americano ha raggiunto livelli pericolosamente alti (36.200 miliardi, pari al 124% del GFP nominale), rendendo sempre più oneroso il ripagamento di tale debito. Ovviamente, la percentuale non è la più alta al mondo. Il debito pubblico giapponese è infatti pari a circa il 260 del GDP. Nel caso degli Stati Uniti, tuttavia, esiste un fattore che nel corso dei decenni ha contribuito in termini significativi all’aumento esponenziale del debito pubblico. Sono le spese per la difesa e i relativi mastodontici budget necessari per tenere in piedi la ragnatela di basi americane sparse per il mondo. La situazione paradossale è che gli Stati Uniti, deindustrializzati in molti settori, detengono tuttavia una colossale industria militare. Può apparire iperbolico, ma i fatti dicono che l’economia americana è “un’economia di guerra.” Il confronto con Ie spese militari del periodo 1940-1945 (5.000 miliardi) giustifica tale affermazione. Il budget 2025 per la difesa proposto dalla Casa Bianca è infatti di circa un miliardo, addirittura in aumento rispetto a quelli degli anni precedenti. In altre parole, un’economia militare senza che esista un conflitto neanche lontanamente paragonabile al periodo della II Guerra mondiale. Neanche le tensioni con la Cina o con l’Iran giustificano tanta paranoia spendereccia.
Sta di fatto che tale paranoia è speculare alla pretesa di presidiare il mondo o almeno di continuare a farlo nonostante l’avvento di nuovi protagonisti nella scena mondiale. Il più agguerrito è ovviamente la Cina e la guerra tariffaria nei suoi confronti è un modo dissimulato di frenare la sua continua crescita anche militare. Sotto questo punto di vista, gli Stati Uniti sono comparabili alla Gran Bretagna: entrambi non si rassegnano ad ammettere che il tempo delle glorie è tramontato.
Ora, esiste una relazione fra la suddetta pretesa e l’atteggiamento del presidente americano, così come esiste una continuità fra molte dele sue velleitarie rivendicazioni territoriali e l’evoluzione degli Stati Uniti nel corso del tempo. Per esplorare tale relazione, conviene spostarsi dall’economia alla storia e soprattutto verso la psicologia dei comportamenti. Molte delle azioni di Donald Trump sono infatti più correttamente interpretabili in termini di psicologia che di economia. Caso mai, l’economia è una delle aree dove egli esercita il suo incontenibile egotismo.
Chi ha avuto la pazienza e la briga di osservare i suoi comportamenti e il suo stile durante la campagna elettorale non avrà mancato di notare come molta della sua attuale retorica verbale continui ad avere uno stile elettorale e auto-incensatorio, salvo un tono meno acceso e per così dire più pacato ma non per questo meno trionfalistico. La sua attuale rilassatezza è infatti quella di chi ha vinto e può quindi permettersi il lusso di essere meno declamatorio e istrionico. Non ne ha più bisogno, perché ormai ha vinto le elezioni. Ma come ha vinto e in che contesto? E qui sta il nocciolo della faccenda.
La vittoria elettorale di Donald Trump potrebbe annoverarsi fa i miracoli della storia politica. In preda a decine di incriminazioni anche penali, sull’orlo del fallimento economico e della prigione, oggetto di ben tre tentativi di assassinio, egli ha superato tutti i suddetti ostacoli ed è riuscito a conquistare un secondo mandato e addirittura a sognarne un terzo (!), anche se la Costituzione americana non lo prevede. Uno stupefacente miracolo, che galvanizzerebbe l’individuo più mite e più umile del mondo. Nel caso di una personalità già pervasa da uno spiccato egotismo e tendenzialmente narcisistica, gli effetti sono ancora più intensi e il miracolo si traduce in uno smisurato delirio di grandezza e spirito di rivalsa nei confronti di tutto e di tutti. Eccolo quindi esigere territori e quasi continenti e combattere il mondo con le sue tariffe, che minacciano di produrre una recessione prima di tutto negli Stati Uniti. Queste sono le previsioni di numerosi analisti, tra cui anche J.P. Morgan e di Goldman Sachs.
Chi dubitasse di tale stretta correlazione fra attuali comportamenti e miracolo elettorale dovrebbe riosservare le scene di un Donald Trump umiliato in tribunale e la sua visibile e mal contenuta frustrazione e comparare tali scene con la baldanza e tracotanza con cui adesso egli accompagna le sue mosse e i suoi decreti. Da notare che secondo la Costituzione le nuove tariffe (di fatto, delle tasse) dovrebbero essere promulgate dal Congresso, cosa aggirata dal Presidente col presto di una supposta situazione di emergenza,
Un’ulteriore conferma che la guerra tariffaria è solo una delle suddette eruzioni di delirio di grandezza è costituita dalle pretese di acquistare la Groenlandia (per supposti motivi di “sicurezza nazionale”), dalle minacce di annessione del Canada e dalla rivendicazione dei minerali rari dell’Ucraina a titolo di risarcimento per gli aiuti militari. Tutte queste pretese non hanno evidentemente niente a che vedere con il debito pubblico o con le supposte ingiustizie commerciali di cui sarebbero vittima gli Stati Uniti, e sono piuttosto il frutto di una megalomania ormai senza controllo. Come accade in tutte le Corti della tradizione, gli ultimi a sconsigliarlo sono i suoi collaboratori. La loro corale docilità è anche una delle principali debolezze di Donald Trump.
Vale comunque la pena di osservare che esse appaiono come la coerente emersione di una sorta di DNA nazionale (con tutto il rispetto per la moltitudine di Americani che non ne hanno nessuna colpa). Le manifestazioni di tale DNA sono note anche se trascurate. Basta pensare all’acquisto della Luisiana e a quello dell’Alaska, al brigantesco furto di metà del Messico e del Dakota indiano o a quello delle Hawaii, al non richiesto acquisto delle Filippine fino a giungere a Portorico. La serie degli “acquisti” o colpi di mano è insomma lunga e incontrovertibile. Lo stesso progetto di acquisto della Groenlandia è anch’esso di vecchia data e risale a ben prima della II Guerra mondiale. In realtà, le citate pretese territoriali di Donald Trump sono la quintessenza di ciò che ha determinato la crescita geografica degli Stati Uniti.
L’affinità storica non elimina comunque la megalomania personale del personaggio. Senza farsi dunque condizionare dagli scenari puramente economici, la matrice dei comportamenti di Donald Trump è caratteriale. L’ostinazione e arroganza con cui egli insiste nella guerra tariffaria, in particolar modo con la Cina, sono del resto speculari all’arroganza del suo gabinetto. Se nei contenuti gli appunti agli Europei di J. Vance a Monaco erano tutto sommato pertinenti, la forma e lo stile (“esiste un nuovo sceriffo a Washington “) erano tipiche dei bulli. Vi è poi un Peter Navarro, il consigliere commerciale, che si riferisce a Trump come al “Boss,” a cui fa seguito il Segretario di Stato Marco Rubio, affermando che adesso ci sono “nuove regole”, ovviamente decise dal Boss prima menzionato. Insomma, un’arroganza strutturale.
Del resto, anche la sicumera (ora smentita dai fatti) con cui il Presidente americano ha sempre affermato che egli avrebbe fatto finire la guerra in Ucraina in un paio di giorni fa parte dello stesso atteggiamento velleitario che caratterizza in maniera sempre più intensa le sue azioni. Sarà una coincidenza, ma la violenza tariffaria scoppia in un momento dove le promesse di rapida fine della guerra in Ucraina sono smentite ogni giorno che passa. Può darsi che sia una compensazione. La voce grossa di Donald Trump col resto del mondo o i veri e propri ricatti (vedi la richiesta alla UE di acquistare 350 miliardi di gas dagli Stati uniti) si ingentilisce o ammutolisce quando si tratta della Russia. Il che sembrerebbe dimostrare che il Presidente americano ha almeno in questo caso il buon senso di essere prudente. E fa bene: Vladimir Putin non vive di trovate pubblicitarie.
Se confrontiamo la vanagloriosa e destabilizzante retorica del Presidente americano con le equilibrate e lucide argomentazioni di Vladimir Putin a proposito dell’Ucraina o quelle di un Lawrence Wong (il Premier di Singapore) a proposito della guerra tariffaria, l’immagine degli Stati Uniti appare malinconicamente impari alla saggezza politica.
11 aprile 2025