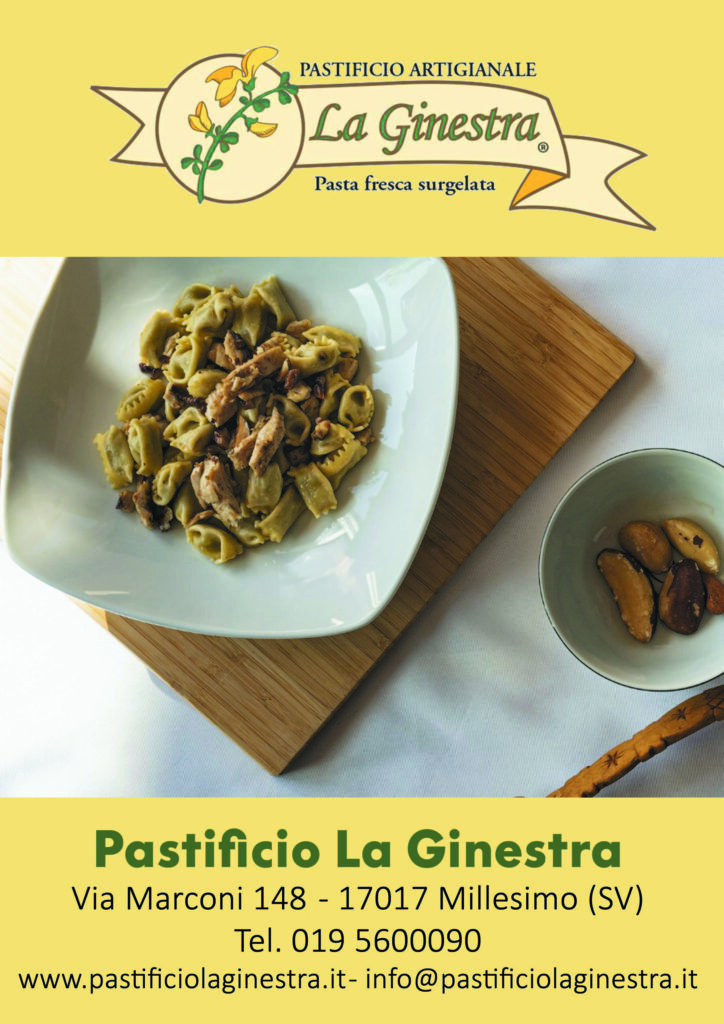di Pietro Sassu
Ai miei due figli (maschi), nel tentativo di trasmettere alcuni rudimenti delle buone maniere, spiegavo l’obbligo delle precedenze che si deve instaurare quando un gruppo di persone si accinge a varcare una soglia o a entrare in un ascensore. Prima le donne, in ordine di età, poi i maschi adulti, sempre in ordine di età (sta alla giovane donna decidere se dare la precedenza – dovrebbe farlo – a un uomo anziano che, però, per galanteria, potrebbe rifiutarla), infine loro due. All’obiezione che passare come capita sarebbe più semplice, rispondevo che questo ordine di precedenze, se condiviso da tutti, sveltisce il transito poiché si evita di fare ressa.
Argomentare il rispetto delle buone maniere quando si riesce a trovarne una giustificazione ragionevole non è difficile: le cose si complicano quando le buone maniere si spiegano con l’esigenza di rispettare le buone maniere: per esempio alzarsi in piedi se nella stanza in cui ci troviamo entra una signora o una persona anziana è un atto che non trova giustificazione pratica, e infatti è sempre più raro, quasi inesistente fra i giovani. Diventa più accettabile fare rispettare l’obbligo di cedere il posto in autobus: quando accade me ne compiaccio, ma se questa cortesia viene riservata a me ci resto male. Chi è al di sotto della soglia di uno standard (peraltro sempre più vago) di buona creanza viene qualificato “cafone”. Il che, in senso stretto, è uno svarione colossale. Nel mondo contadino e, in genere, nelle società tradizionali, i rapporti interpersonali sono regolati da comportamenti che noi potremmo definire quantomeno complicati. Persino all’interno del nucleo famigliare resistono atti cerimoniosi che la modernizzazione non ha saputo smantellare.
Qualche esempio tratto dalla Sardegna può tornare utile perché si possono cogliere comportamenti “tradizionali”, a volte tipici, accanto ad altri non dissimili da quelli praticati in ambiente borghese. Non si dà sulla voce a un anziano (sempre interpellato col “voi”, compresi i genitori) e nelle tavolate continua a occupare il posto d’onore: recita un proverbio della Gallura “iscula la banca chi no ha balba bianca” (povera tavola senza un vecchio). È quanto resta del rigido principio di autorità degli assetti familiari dettati da una economia sempre più marginale e poco si discostano dalle regole rispettate in altri contesti, compreso quello borghese.
Il banchetto della tosatura in Sardegna
Ci sono atti cortesi, all’interno di una comunità tradizionale, che restano regolati da una funzionalità riconoscibile. Quando il pastore sardo deve tosare il gregge chiede l’aiuto dei vicini e degli amici; però nel ricevere aiuto contrae un piccolo debito: egli potrebbe essere chiamato a effettuare le stesse prestazioni – se è un agricoltore saranno altre, ma misurate per analogia di impegno. Si offenderebbero se qualcuno parlasse di “scambio”: ciascun atto è vissuto solo come una gentilezza senza contropartite. Superate le penurie del passato, la richiesta di prestito di derrate alimentari è molto rara, ma se si chiedono prodotti aridi (riso, grano, farina, zucchero) il recipiente sarà a raso mentre la restituzione sarà a colmo; non è il pagamento di interessi, è un atto cortese, come è cortese non restituire vuoto un cestino o un recipiente che conteneva doni alimentari (frutta, dolci, o altro). Che questo criterio della restituzione (proprio con la formula del raso e del colmo) fosse sancito da antichi regolamenti di ampia diffusione è vero, ma nessuno lo sa, pur continuando a rispettarlo come gesto di buona creanza.
Nelle feste della tosatura il banchetto all’aperto è quasi un balletto di buone maniere. Gli uomini accendono il fuoco e arrostiscono agnelli e maialini; quando la cottura è quasi a punto arrostiscono a parte il fegato (che, come è noto, ha una cottura rapida) per girare tra gli ospiti e offrirlo accompagnato da un bicchiere di vino. Le carni poi, adagiate su vassoi di sughero a conca che assorbono un poco il grasso, vengono tagliate a piccole porzioni per agevolarne il consumo, dato che non è previsto l’uso di posate. C’è un continuo passare tra gli ospiti per essere certi che tutti siano serviti con assiduità. Ho partecipato a diverse feste di tosatura e ad altri banchetti all’aperto: i comportamenti erano sempre gli stessi, con variazioni minime. Quanto alle donne, la qualità più apprezzata è di essere zeniosa, per dire garbata, gentile, generosa, attenta: una ragazza così può non essere bella, ma certamente non le mancheranno i corteggiatori.
Che arrostire spetti agli uomini perché questa predisposizione del cibo è la più adatta quando ci si rivolge all’esterno (la pentola è per la famiglia) è un tratto culturale universalmente condiviso, come dimostra Lévi-Strauss in Le origini delle buone maniere a tavola. Tra gli esempi, segnala anche tra le tribù nordamericane la rigida abitudine di arrostire secondo una divisione di compiti che abbiamo segnalato come ancora attiva tra i pastori sardi (un esempio fra tanti). Che lo sappiano o no, anche adesso per gli americani è impensabile che il barbecue non sia un uomo a curarlo, rispettando protocolli cortesi di arcaica ascendenza.
Codici delle performance musicali
Nella pratica viva della musica di tradizione orale le buone maniere sono inscindibili da comportamenti cerimoniali che hanno come scopo la buona riuscita della performance. Nelle gare in ottava rima, nello scambio di frecciate degli stornelli, nelle esibizioni virtuosistiche non si interrompe il cantore o lo strumentista per imporsi a lui: sarebbe inammissibile anche se commette errori e non è all’altezza del ruolo che si è assegnato. Se qualcuno ha assistito alla tammurriata di una paranza napoletana o di qualsiasi altro gruppo di cantori, suonatori e danzatori delle regioni meridionali (di cafoni, insomma), noterà che si “entra” da solisti liberamente, donne e uomini, giovani e anziani; si può entrare subito dopo per affiancare il “solista”, specialmente nel ballo, ma con un ruolo subordinato. Il ricambio avviene, ma non troppo presto né troppo tardi: non prima che il protagonista si sia espresso compiutamente ma in tempo per prevenire quei segni di stanchezza che potrebbero compromettere la “tenuta” di una tensione che deve crescere sino a sfiorare il parossismo. C’è un erotismo latente che si svela con un controllo costante: i corpi si sfiorano appena e non è ammesso un contatto troppo ravvicinato. Buone maniere musicali e coreutiche da tutti condivise perché evitano la ressa: tutto si svolge entro uno spazio di rispetto delimitato da chi non partecipa attivamente, ma potrà “entrare” a suo piacimento, cogliendo però il momento più adatto.
Formalizzazione dei valori condivisi
Nessuno porta più la spada al fianco, ma si continua a dare la destra non certo per offrire protezione, ma come forma di rispetto e di buona educazione. Comportamenti e maniere che tanto nelle società tradizionali quanto nelle società evolute nascono sempre da necessità pratiche o dall’esigenza di instaurare atti protocollari che evitano rapporti interpersonali brutalmente diretti. I colonizzatori spagnoli reagivano con stupore alle cerimonie di gentile accoglienza ricevute dai selvaggi che stavano per sterminare. Il fatto è che nessun gruppo umano può costituirsi senza norme culturali condivise che i comportamenti esteriori rendono visibili, persino idealizzandoli: in altri termini le “buone” maniere hanno lo scopo, indipendentemente dal grado di civilizzazione, di praticare e rendere visibili i “buoni” principi.
22 marzo 2025